Carcinoma della tiroide: l’evoluzione dei trattamenti e la gestione del rischio
Il professor Michele Minuto illustra le strategie più attuali, dalla sorveglianza attiva alla chirurgia su misura, alla luce di quanto indicato dalle linee guida 2025
focus tiroide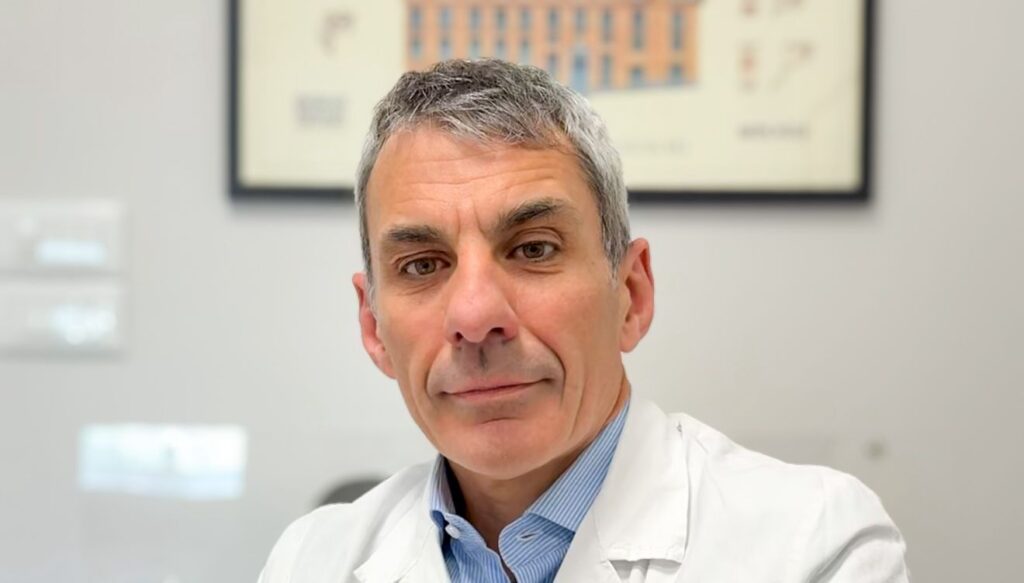
La gestione clinica del carcinoma della tiroide sta vivendo una fase di importante cambiamento. Con questo approfondimento inauguriamo un focus dedicato alle patologie tiroidee, analizzando come l’avanzamento delle tecnologie diagnostiche e la pubblicazione nel 2025 dei nuovi protocolli internazionali ne abbiano ridefinito l’approccio clinico. L’attenzione si sposta oggi dalla massimizzazione delle cure alla personalizzazione del trattamento.
Ne parliamo con Michele Minuto – professore associato di Chirurgia generale presso il Dipartimento di scienze chirurgiche (DISC) dell’Università degli studi di Genova – che ha scelto Montallegro per la sua attività in libera professione.
– Quali novità introducono le linee guida 2025 nel trattamento del carcinoma tiroideo?
«L’aggiornamento dei protocolli si è reso necessario poiché negli ultimi anni assistiamo a un aumento dell’incidenza delle diagnosi.
Questo incremento non riflette necessariamente un aumento dell’aggressività biologica della malattia, ma è piuttosto legato alla maggior diffusione e fruibilità delle metodiche diagnostiche, in particolare l’ecografia. Oggi riusciamo a individuare noduli nel 50% della popolazione cinquantenne, intercettando formazioni sospette che conducono all’ago aspirato e, conseguentemente, alla diagnosi di tumore in stadi molto precoci. In ogni caso è fondamentale considerare il rischio clinico reale: la sopravvivenza a cinque anni per questa neoplasia è del 98,5%».
– Confermata la diagnosi, qual è l’iter terapeutico?
«In virtù dell’ottima prognosi, non siamo obbligati a trattare in maniera aggressiva tutti i pazienti. Esiste l’opzione della sorveglianza attiva: alcuni carcinomi possono essere semplicemente monitorati nel tempo.
Questa strategia deve essere tuttavia attuata esclusivamente in centri di riferimento e gestita da un team multidisciplinare composto dal chirurgo endocrino, dall’endocrinologo, dal medico nucleare e dall’anatomopatologo.
Un livello superiore di intervento è rappresentato dalla termoablazione, metodica riservata a casistiche selezionate. Si tratta di una procedura che utilizza radiofrequenze, micro-onde o laser per distruggere il nodulo con l’impiego di alte temperature».
– Quale approccio definisce invece lo standard chirurgico attuale?
«La chirurgia rimane il trattamento di riferimento, ma offre diverse opzioni mirate a preservare la qualità della vita. L’approccio meno invasivo è la lobectomia tiroidea, ovvero l’asportazione limitata all’emitiroide interessata dal tumore. Questa scelta comporta vantaggi clinici rilevanti: conservando metà ghiandola, il paziente potrebbe non necessitare della terapia sostitutiva con levotiroxina a vita. Inoltre, si espone a rischio un solo nervo ricorrente (deputato alla mobilità delle corde vocali) e il decorso post-operatorio risulta estremamente rapido».
– In quali casi, invece, la tiroidectomia totale resta imprescindibile?
«La tiroidectomia totale rappresenta l’intervento tradizionale e comporta l’asportazione dell’intera ghiandola. È una procedura con un impatto diverso sulla vita del paziente – che sarà vincolato all’assunzione di farmaci sostitutivi per sempre – e presenta una morbilità post-operatoria lievemente maggiore. Tuttavia, in casi specifici in cui il tumore manifesta caratteristiche aggressive, il chirurgo esperto deve saper riconoscere il rischio oncologico e intervenire radicalmente. In queste situazioni si procede con la tiroidectomia totale, l’eventuale asportazione dei linfonodi del collo e, successivamente, una terapia radiometabolica mirata».
– Alla luce di ciò, lo screening preventivo di massa è consigliabile?
«Assolutamente no. Lo screening per il nodulo tiroideo è controindicato dalle stesse linee guida internazionali. L’esperienza della Corea del Sud, dove fu introdotto uno screening di massa vent’anni fa, ha dimostrato che questa pratica porta a trattare un numero di casi sproporzionato rispetto al necessario, senza apportare benefici in termini di mortalità. In Italia, dove l’incidenza dei noduli è endemica sopra i 50 anni, non è indicato cercare la malattia in assenza di sintomi specifici o familiarità.
La prevenzione primaria passa piuttosto attraverso l’uso costante del sale iodato che permetterà di ridurre drasticamente la formazione dei noduli nelle future generazioni».