A tu per tu con Matteo Formica
Un ritratto del professionista e dell'uomo: dalla vocazione nata in famiglia ai progressi della chirurgia protesica, fino alla passione per la montagna e il tennis
Mi dica, dottore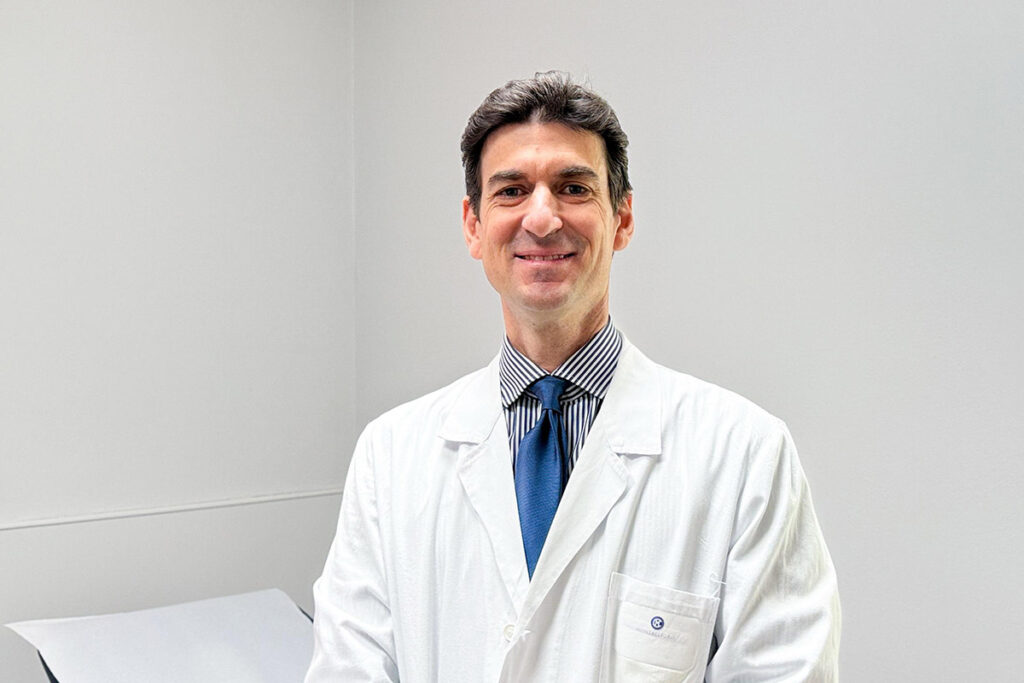
È il direttore della Clinica Ortopedica dell’IRCCS Ospedale San Martino. Matteo Formica, 45 anni, specialista in Ortopedia, dedica particolare attenzione alla chirurgia vertebrale e a quella protesica di anca e ginocchio, portando con sé un’esperienza internazionale e una solida formazione accademica. Lo abbiamo incontrato in Montallegro, struttura che da anni ha scelto per l’attività in libera professione, per un dialogo “a tu per tu” che va oltre il camice, alla scoperta della vocazione, delle passioni e della visione che guidano il suo lavoro quotidiano.
– Prof. Formica, c’è stato un evento o una persona che l’ha ispirata nella scelta della professione medica?
«Sì, sono nato in una famiglia di medici, mio padre era ortopedico. Ho sempre respirato quest’aria e sono rimasto affascinato dal suo lavoro, con una predilezione per l’ambito chirurgico. Ricordo le immagini e i video di interventi che guardava: la visione potrebbe turbare un bambino, invece a me interessava. Avere una persona che ti spiega la propria professione può attrarre o allontanare: nel mio caso, la figura paterna mi ha decisamente affascinato».
– E perché, tra le tante specialità, ha scelto proprio l’Ortopedia?
«Quando si entra a Medicina si ha una visione d’insieme e lì ho capito che mi piaceva l’ortopedia, la biomeccanica articolare. È un’attività spiccatamente manuale, in cui si ragiona su concetti quasi meccanici per ricostruire parti del nostro corpo. È un po’ come usare le mani per aggiustare qualcosa a casa, ma lo si fa in sala operatoria».
– Quali sono stati i progressi più significativi che ha visto nella sua specialità negli ultimi 15-20 anni?
«In ambito ortopedico, i progressi sono stati enormi, soprattutto nei materiali e nelle tecnologie. Se parliamo di chirurgia protesica, traumatologia o chirurgia vertebrale, i materiali si sono evoluti tantissimo: siamo passati dall’acciaio al titanio, fino agli impianti in carbonio, con un’incredibile evoluzione in termini di biocompatibilità, integrazione con l’osso e resistenza all’usura nel tempo. A questo si aggiungono le tecnologie di imaging, la navigazione intraoperatoria, la realtà aumentata e la robotica che si interfacciano tra loro per garantirci una precisione di impianto sempre maggiore».
– C’è un episodio particolarmente significativo o emozionante che ricorda della sua carriera?
«Sicuramente il primo approccio con la sala operatoria, da giovanissimo studente di medicina. Lì dentro è tutto diverso rispetto a ciò che si vede nelle corsie: c’e grande pulizia, precisione e bisogna prestare la massima attenzione a ciò che si fa e si tocca. Vedere il paziente addormentato e poter lavorare su di lui è un’esperienza che emoziona profondamente, un momento di grande impatto emotivo. Ci sono studenti che, al primo approccio, svengono o si sentono male e capiscono di non essere portati per la chirurgia. Per me, invece, le sensazioni provate sono state la conferma della mia vocazione».
– Che consiglio darebbe a un giovane medico che vuole avvicinarsi alla sua specialità?
«Può sembrare una banalità, ma il consiglio è di essere estremamente preparati culturalmente. Oggi, con internet, è facile accedere a video di tecniche chirurgiche, ma questa “facilità” non deve mai prescindere da uno studio accurato della letteratura scientifica. Prima del gesto chirurgico, è fondamentale l’indicazione: bisogna sapere quale risultato darà quella tecnica su quel determinato paziente. Un gesto tecnico perfetto eseguito su un’indicazione sbagliata garantirà sempre un insuccesso».
– C’è qualcosa che vorrebbe cambiare del sistema sanitario italiano?
«Nella complessità del sistema sanitario nazionale, permane una forte dicotomia tra gli ospedali pubblici e le strutture private convenzionate. Queste ultime potrebbero e dovrebbero dedicarsi alla chirurgia elettiva, non d’urgenza, così da decongestionare i grandi ospedali e permettere loro di concentrarsi sulle patologie complesse e gli interventi urgenti. Inoltre, è cruciale ottimizzare le risorse economiche, che dovrebbero essere maggiormente dedicate al personale medico e all’acquisizione di tecnologie all’avanguardia».
– Togliamo il camice. Quali sono i suoi hobby preferiti?
«Amo moltissimo sciare, la montagna è il luogo dove mi sento in assoluto più libero e tranquillo. Quindi gli sport invernali, ma anche le camminate estive all’aria aperta, soprattutto in posti poco affollati. Noi medici vediamo tantissime persone ogni giorno, per cui nel tempo libero si cerca un po’ di pace. E poi il tennis, la mia grande passione fin da quando ero piccolo. Non dico che fossi una giovane promessa, ma quasi… poi ho smesso verso i 16-18 anni».
– Dritto o rovescio, qual è il pezzo forte della casa?
«Un tempo era il dritto. Adesso, devo dire, vado molto fiero del mio rovescio a una mano, d’altri tempi. D’altronde, il mio idolo è sempre stato Roger Federer».
– E in montagna, c’è una valle o una cima che è il suo luogo del cuore?
«La Val Veny, in Val d’Aosta. È un posto strepitoso, dove d’inverno si scia in uno scenario incredibile sotto i ghiacciai del Monte Bianco, e d’estate si fanno passeggiate spettacolari».
– La carriera medica è totalizzante. Come riesce a mantenere un equilibrio con la vita privata?
«Famiglia, amici, figli sono importantissimi e bisogna saper tracciare una linea netta tra il lavoro e la vita privata, perché altrimenti la nostra professione fagocita tutto. È esponenziale: più fai, più faresti. Io ho quindi imparato a ritagliarmi i miei spazi, decidendo che ci sono giornate da dedicare alla famiglia, allo sport o ad andare a vedere le mie figlie giocare».
– Qual è il suo legame con Montallegro?
«Posso dire di esserci nato e cresciuto. Ho sempre visto mio padre lavorare qui; lo aspettavo nel piazzale quando ero ragazzino. È una struttura dove mi sento a casa: è veramente una seconda casa. C’è poi un’organizzazione rodata, in cui mi basta alzare il telefono per organizzare in un attimo ciò che è meglio per il paziente, da un esame radiologico a un trattamento fisioterapico, fino a un intervento chirurgico. Qui posso lavorare in modo tranquillo e sereno».